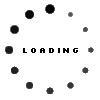Estratto della Tesi di Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica “Dove Cera Aperosità” di Francesca Salcioli, sotto la guida di Tiziana Tacconi e di Mariarosa CalabreseTiziana Tacconi e di Mariarosa Calabrese. Per un possibile approccio artiterapico alla cleptomania.
Il Signor V è il protagonista di un percorso artiterapico sperimentale, incentrato sulla lavorazione della cera d’api grezza, nel contesto della fattoria sociale Bosco di Museis, diretta da Renato Garibaldi e immersa nei boschi carnici della provincia di Udine.
Il Signor V è un paziente psicotico di cinquant’anni, con ritardo cognitivo, affetto da crisi epilettiche e spiccate tendenze cleptomani, che si concentrano particolarmente su denaro e succhi di frutta. “Se rimproverato, s’innesca in lui un conflitto interiore che lo porta a negare l’accaduto e racchiudersi in uno stato di rabbia con se stesso”, dichiara il suo psicoterapeuta, comportamento che lo induce infine ad adottare “comportamenti aggressivi e compulsivi nei confronti di chi lo riprende”. Il Signor V soffre di deficit di coordinazione (probabilmente acuito dall’assunzione di farmaci antipsicotici), la componente fine-motoria risulta degradata e la sua vita relazionale è caratterizzata da una spiccata sensibilità e grande fragilità emotiva.
In accordo con i responsabili della fattoria sociale e del terapeuta, propongo di coinvolgere il Signor V in un percorso artiterapico per lui appositamente progettato e che lavori in primis simbolicamente, attraverso il gesto artistico, sul concetto di abbondanza e di scambio, quali alternative positive rispetto alla sensazione di carenza e al bisogno di rubare. Condividiamo che il progetto dovrà al contempo facilitare la sperimentazione di sensazioni positive, dolcezza, distensione e rilassamento, incentivando l’autostima e l’autonomia del protagonista, al fine di incentivare la propria percezione di unicità e valore umano, sociale e produttivo, essenziale per una buona relazione con se stesso e con la comunità.
Cleptomania: il Corpo e l’Amore, la Mater e la Materia.
Per confezionare un adeguato percorso artiterapico per il Signor V, mi soffermo inizialmente sulle radici e i significati simbolici che sottendono la cleptomania, che è attualmente classificata in psichiatria come un disturbo del controllo degli impulsi (Shulman, Terrence Daryl, Something for Nothing: Shoplifting Addiction & Recovery, 2004), che concerne l’incapacità di astenersi dalla voglia di rubare oggetti, per motivi diversi dall’uso personale o di lucro. Se infatti il desiderio del furto è innato nella natura umana (e animale), nella nostra cultura lo spartiacque fra la salute e la patologia si gioca sulla capacità o meno di sapervi resistere. Ai fini artiterapici risulta interessante soffermarsi a riflettere sulla componente di desiderio e di amore nell’impulso cleptomane. Come qualsiasi altro disturbo del controllo degli impulsi, la cleptomania sembra recare in sé, dal punto di vista psicoterapeutico, un primigenio “vuoto d’amore” o un vuoto nella genesi dell’amore. Nell’esperienza umana, il territorio psichico del desiderio e dell’amore è spesso scivoloso, dove il soggetto e l’oggetto d’amore possono rischiare una lontananza incolmabile, fisica e di mutua comprensione, che impedisce la sana reciprocità, ovvero la capacità del soggetto di farsi oggetto e dell’oggetto di divenire soggetto d’amore. La cleptomania, con la sua incapacità di resistere al desiderio, fino a giungere al furto, rappresenta in un certo senso un cortocircuito dell’amore, che impedisce il piacere della reciprocità, libero scambio ed equilibrio, basi fondamentali di un rapporto d’amore. Proprio su questi cardini, decido allora di imbastire la mia proposta artiterapica, consapevole che l’unico luogo psichico e fisico veramente privilegiato, dove godere dell’onere e onore della piena responsabilità dell’amore, è il proprio corpo e il proprio sé. È in primis nella relazione con se stessi che si può lavorare sull’amore e sul desiderio, nonché sperimentare pienamente l’altalena misteriosa di essere al contempo oggetto e soggetto d’amore: solo un sano amor proprio insegna a proiettare, in maniera altrettanto sana, l’oggetto d’amore sull’altro, senza frustrazione alcuna. Il corpo, in ottica artiterapica, è rappresentato dall’opera d’arte e qualsiasi atto di cura e di dedizione verso questa equivale a un atto di cura e dedizione verso se stessi.. In effetti l’arte è per definizione e natura un’attività d’amor proprio, dove la dimensione del piacere è innanzitutto nel dialogo intimo, attraverso la materia, prima di divenire un dialogo di piacere con l’osservatore esterno. L’amore giunge alla coscienza, come ogni altro pensiero e consapevolezza umana, passando per la corporeità (Umberto Galimberti, Il corpo, Milano, 1983) e il corpo della materia artistica è un corpo altro, nuovo, tutto da toccare, che si offre all’artista ancora puro e di cui ci si può rivestire, specchiandosi, sperimentando la rinascita.
Se la psicoterapia cognitivo comportamentale permette buoni risultati in presenza di un’altrettanto radicata motivazione, con un paziente psicotico e con ritardo cognitivo la terapia della parola riscontra oggettive difficoltà d’applicazione, poiché il paziente è solo parzialmente conscio di sé. In quest’ottica l’approccio terapeutico artistico può risultare molto più fertile, poiché sorpassa sorprendentemente i livelli emersi della coscienza, per inaugurare un dialogo intimo e diretto con gli aspetti più profondi della personalità. Da un punto di vista psicoterapeutico, si potrebbe scavare all’origine di quel vuoto interiore, capace, come un vortice centripeto, di attirare a sé oggetti altrui, oggetti d’amore vietati o impossibili, affondando le radici nell’infanzia, probabilmente complessa, del paziente e nei primissimi rapporti intimi e famigliari vissuti dallo stesso e, in particolare i primissimi territori di scambio affettivi e del rapporto del paziente con la madre. In ottica terapeutica artistica, risulta invece di primaria importanza il nuovo rapporto che il paziente può instaurare con la mater – ia, nuova madre e matrice, controparte da conoscere, toccare e plasmare per il proprio piacere creativo e per il proprio desiderio di amare ed essere amato, in un sano scambio di dare e avere. Da un punto di vista artiterapico, è possibile quindi colmare simbolicamente e materialmente quel vuoto misterioso e interiore del paziente e risarcire il vuoto con “altro”: non più oggetti creati dalla creatività altrui e posseduti da altre mani, ma oggetti propri, creati dalla propria creatività e unicità e posseduti come tali, valevoli di attrarre su di sé l’attenzione e liberi di essere valorizzati attraverso il dono, lo scambio o la vendita. L’obiettivo del laboratorio di terapeutica artistica risulta quello di rendere ricco a prescindere il paziente, così ricco da lenire quel senso di vuoto interiore che grida una povertà continua. Solo chi è ricco davvero, e così si sente, può nella tranquillità sperimentare anche il dare, quale controparte perfetta ed armonica dell’avere, rigenerando l’equilibrio osmotico del ricevere e lasciare andare, alla base dell’amore e di tutta la vita umana e naturale.
L’ape, l’oro e la cera.
L’approccio terapeutico artistico riconosce un’importanza fondamentale ai materiali e alla mater materia insita in essi, al fine di garantire la più piena esperienza creativa e psichica verso il benessere, l’evoluzione e l’equilibrio, e particolare rilevanza viene riconosciuta a quei materiali in qualche modo correlati al setting che ospiterà le attività. La fattoria didattica e sociale ospitante Bosco di Museis coltiva quale sua principale attività l’apicoltura e, di conseguenza, una materia di grandissimo pregio e reperibile in alte quantità all’interno dell’azienda ospitante è la preziosa cera d’api. In fase valutativa e teorica dell’effettuabilità ed efficacia del laboratorio artiterapico, insieme all’azienda viene valutata la simbologia profonda della cera, del miele e dell’ape, anche in relazione al disturbo della cleptomania.
Da un punto di vista mitologico, l’ape “regina suprema dell’età dell’oro”, come chiamata da Federico Garcia Lorca (Il Canto del Miele, Poesie. Libro de poemas – Suites, 2011), secondo una leggenda egizia nacque dalle lacrime cadute sulla terra del Dio Sole Ra, venendo alla luce come puro insetto solare. A Sais, nel Basso Egitto, lo stesso templio del dio Neith era soprannominato “casa dell’ape”. Il Dio Mithra, venerato dagli Antichi Babilonesi attorno al 1600 a.C., era rappresentato da un leone, con un’ape fra le fauci. Nella lingua locale l’ape era detta Dabar, termine che significava anche la Parola divina, usato successivamente anche presso gli antichi Ebrei per indicare il Messia. In lingua ebraica, l’ape viene chiamata Dbure, dal termine Dbr, col significato di “discorso”, manifestando il suo legame con l’eloquenza e l’intelligenza. Nella religione ellenica, Zeus, detto anche Melisseo, sarebbe stato nutrito di solo miele dalle api di Creta, grazie a sua madre Melissa, il cui nome significa “colei che è datrice di miele”. Una volta cresciuto, Zeus, per dimostrarle la sua gratitudine, liberò Melissa dalle spoglie umane, trasformandola proprio in un’ape. Le sacerdotesse della Dea Madre Demetra, ad Eleusi, erano chiamate “api”. I Greci antichi ritenevano che le api fossero nate naturalmente dal corpo dei cadaveri, simboleggiandone la resurrezione e la rinascita. Esse erano venerate come messaggere fra la Terra e il Cielo e generose ambasciatrici di preghiere. Anche nella religione indiana le api godono di una particolare importanza mitologica e simbolica: Visnù, Krishna e Indra sono chiamati Madhava, ovvero “nati dal nettare”, e Kama, dio hindu dell’amore, è rappresentato con una corda d’arco fatta di api. Vishnu e Shiva sono ritratti rispettivamente come un’ape posata su un loto e su un triangolo. Nel mondo cristiano le api hanno spesso simboleggiato il Cristo, con il loro miele e pungiglione, a simboleggiarne rispettivamente la misericordia e la giustizia. L’alveare diviene metafora cristiana della vita casta, regolata e caritatevole delle comunità monastiche. Una sottile parentela unisce in questo le celle delle api e quelle dei monaci, in un unico alveare simbolico di condivisione. Sempre in contesto cristiano, si narra che San Giovanni Crisostomo, detto “dalla bocca d’oro”, fosse nato con uno sciame d’api volteggiante intorno alla bocca, metafora della dolcezza della sua futura predicazione. Sempre alle api è legato il primo miracolo di Santa Rita che, ancora in culla, fu vista oggetto delle cure premurose delle api, che la nutrivano direttamente sulle sue labbra, con miele profumato. L’ape è emblema della castità e le donne ateniesi che partecipavano alle feste Tesmoforie prendevano il nome di mélissai, astenendosi per tre giorni da ogni contatto sessuale, digiunando per un giorno e giacendo a terra su giacigli di agnocasto, pianta dal note potere afrodisiaco. L’ape è al contempo sempre messaggera d’amore, testimone dei legami di purezza e fedeltà: nel folclore tedesco, mettersi di fronte a un alveare costituiva una prova di purezza per le giovani spose. Il miele, frutto dell’instancabile dedizione delle api, chiamato da Virgilio “dono della rugiada”, è stato al centro di riti di propiziazione e magia, legati soprattutto alla prosperità, fertilità e amore, e nei riti di purificazione, soprattutto in relazione con il latte. Era utilizzato nella consacrazione di sacerdoti e sacerdotesse e nella benedizione dei templi. Presente anche nei più salienti riti di passaggio della vita, quali nascita, matrimonio e morte, il miele veniva offerto quale buon augurio e spalmato sulla soglia di casa delle nuove coppie di sposi, usanza da cui deriva il modo di dire “luna di miele”.
Da un punto di vista letterario antico, le api sono sempre state messe in relazione con l’elemento divino: Virgilio, nelle Georgiche, afferma che le api “hanno una parte della mente divina e il respiro dell’etere” e nell’Eneide paragona le api, per la moltitudine in volo e del ronzio, alle anime che volano verso Lete. Porfirio, filosofo e teologo greco vissuto nel III secolo, racconta che gli antichi chiamavano melìssas le anime avviate alla nascita, destinate a vivere con giustizia e a ritornare indietro, dopo aver compiuto e realizzato il volere degli dei. Nell’Ippolito di Euripide viene presentata una nuova testimonianza del primato di purezza divina, legato all’ape: l’eroe offre ad Artemide una corona di fiori proveniente da un prato incontaminato, dove il pastore non osa pascolare il suo gregge e in cui solo l’ape può accedervi, in quanto luogo di grande purezza.
Da un punto di vista storico, le api attualmente vivono in tutto il pianeta, tranne che nelle estreme regioni polari. Prima del XVI secolo tuttavia erano presenti solo nel Vecchio Mondo, dove apparvero prima della comparsa dell’uomo. Già l’uomo primitivo, vivendo procurandosi ciò che la natura offriva, godeva della dolcezza del miele, recuperandolo dai nidi d’ape. La prima iconografia dei rapporti fra l’uomo e l’ape risale al Neolitico, circa 9000 anni fa. Rinvenuta nel 1921 a València, in Spagna, essa è una raffigurazione di un nido d’api e di un cacciatore di miele sulle pareti di una grotta, detta Cueva della Araña. L’apicoltura come noi la conosciamo nacque più tardi, quando l’uomo, da cacciatore nomade, divenne agricoltore e iniziò ad allevare le api in contenitori appositi. Nei tempi antichi l’ape ebbe un’importante funzione simbolica e magica, nonché economica, in quanto il miele, considerato dai Greci “cibo degli dei”, fu il primo dolcificante conosciuto dall’uomo. L’apicoltura era già nota al tempo dell’Antico Egitto, testimoniata da diversi reperti, fra i quali una raffigurazione, sulla tomba PA-BU-SA a Tebe (625-610 a.c.), di un apicoltore che raccoglie il miele da un’arnia in terracotta a forma di anfora. Una conoscenza più scientifica sul mondo e sulla natura dell’ape fu possibile con Aristotele, nel 300 a.C., che l’introdusse in diversi testi, ovvero La storia degli animali, Trattato della generazione e Le parti degli animali. Aristotele fu il primo a osservare il comportamento delle api bottinatrici, responsabili dell’impollinazione incrociata o eterogama, ovvero che coinvolge due piante della medesima specie, favorendo la variabilità genetica e la biodiversità. Con l’introduzione del microscopio, dall’inizio del Seicento, cambia notevolmente lo spirito dello studio scientifico e il biologo olandese Jan SVammerdam scoprì per primo il sesso femminile della regina, produttrice delle uova dell’intera colonia, e il sesso maschile dei fuchi. I suoi studi, con descrizioni minuziose e importantissime delle parti anatomiche dell’ape, furono pubblicati, molto dopo la sua morte, in Biblia Naturae del 1737–1738. Un ulteriore rilevante contenuto alla conoscenza dell’anatomia dell’ape fu offerta dalle ricerche di Rèaumur, raccolte nel 1734 nelle Memorie per servire alla storia degli insetti. Il biologo austriaco Karl Von Frish, insignito del Premio Nobel in Fisiologia e Medicina nel 1973, con i suoi studi sul comportamento delle api, ha scoperto e interpretato la loro celebre e preziosa danza di orientamento.
Da un punto di vista agrario e agronomico, nel corso dei secoli si è assistito a un’evoluzione delle tecniche apistiche, passando dall’uso di arnie costituite da un solo contenitore a favi fissi alla scelta di telai mobili. Il prototipo di arnia primitiva è verosimilmente un tronco cavo, simile alle arnie che si possono osservare anche al Bosco di Museis. Ai tempi degli antichi romani e greci era in uso l’arnia Columella, costituita da tavole a forma di parallelepipedo, posta orizzontalmente con il fondo posteriore mobile. All’epoca di Carlo Magno era largamente utilizzata l’arnia di paglia intrecciata. Un netto miglioramento delle tecniche apistiche si ebbe quando si decise di ampliare l’arnia, sovrapponendogli un melario dove le api potessero immagazzinare miele e l’apicoltore raccoglierlo, senza distruggere il nido di covata. L’invenzione dell’arnia a telai mobili ha segnato definitivamente l’evoluzione dell’apicoltura.
Dal punto di vista biologico, il nome scientifico Apis mellifera testimonia la natura inscindibile, agli occhi umani, dell’ape dal miele, prodotto del suo lavoro e della sua spiccata laboriosità: si stima che alle api sia necessario un volo di 530mila chilometri, per generare un chilo di miele. Quella dell’ape domestica costituisce la società animale più ammirata e studiata dalla scienza: si tratta di una società matriarcale, monoginica e pluriannuale, formata da numerosi individui appartenenti a tre caste alate. Normalmente l’alveare ospita una regina (unica femmina fertile), fino a 100mila operaie (esemplari femmine sterili) e, tra aprile e luglio (in Europa), fino a 2mila maschi, detti anche fuchi, destinati alla riproduzione. Nella cella reale è allevata la regina, straordinariamente prolifica, con il compito prezioso di deporre le uova e di assicurare la coesione della colonia. A differenza delle api operaie, essa è priva dell’apparato per la raccolta del polline e ha, in relazione alla sua intensissima attività riproduttiva, un metabolismo più elevato di quello delle operaie. La sua è una vita relativamente lunga, che può raggiungere i 5 anni. I maschi, più grandi delle operaie ma più piccoli della regina, sono impossibilitati a trarre il nettare dai fiori, hanno il compito di fecondare le nuove regine e mantenere la temperatura della covata.
Le api operaie si ripartiscono le varie attività sociali, secondo classi di età, cui corrispondono cicli naturali di sviluppo e di regressione biologica. La giovane operaia ha come primo compito quello di ripulire e levigare le celle di nuova costruzione o quelle che devono essere riutilizzate. Successivamente, l’ape operaia diventa capace di produrre la pappa reale e di occuparsi dell’alimentazione delle larve. Allo scadere della seconda settimana di vita, l’ape non produce più pappa reale, ma cera, e passa a costruire i favi. Successivamente l’ape migra all’esterno dell’alveare, prima a scopo di difesa e poi per occuparsi della raccolta del nettare. È in questa veste matura che l’ape operaia raggiunge il massimo della propria preziosa vitalità, avendo sviluppato notevolmente i centri di coordinazione cerebrali (corpi peduncolati). Essa si rivela capace di prestazioni comunicazionali straordinarie, quali la possibilità di trasmettere informazioni attraverso un linguaggio simbolico (si sono scoperti ad oggi fino a otto tipi di danze simboliche), sull’esatta ubicazione delle sorgenti di cibo, anche se molto distanti (fino ad alcuni chilometri), e comunicando dati certi sui rapporti di posizione fra campo fiorito, alveare e sole. Alla fine di poco più di un mese di vita, l’ape operaia riprende mansioni casalinghe di ventilazione e riscaldamento del nido, di pulizia e di difesa. Dopo trenta o quarantacinque giorni di esistenza, avvertendo ormai prossima la propria fine, si allontana dalla comunità, morendo infine lontana da essa, per non contaminare l’alveare col suo cadavere. Nella sua vita caratterizzata da nobile semplicità, percezione comunitaria e dedita laboriosità, risiede il segreto dell’ape e del suo secreto, ovvero del miele e della cera. L’ape è simbolo del mistero della coordinazione e della condivisione perfetta, dell’armonia del prendere e del dare. L’ape è operaia e regina della trasformazione, capace di raccogliere il nettare, il frutto della terra nutrita di luce, e, con operazione squisitamente alchemica, trasformarlo in miele, puro oro estivo, e in cera d’api, pura possibilità, nell’ombra delle splendide chiese ortodosse, ancora, di luce. L’ape fa del suo corpo un tempio della trasformazione: esso, nell’alternarsi delle cromie del giallo e del nero, sembra testimoniare la fede semplice nella sacra alternanza della luce e del buio, del giorno e della notte, della vita e della morte. Essa vive e si consuma, con la serenità di chi non conosce l’Ego. Il suo vivere è consumarsi, come una candela di cera, che offre la sua luce, fino alla fine. L’ape è vestale della ciclicità, del tempo che muta e ritorna su se stesso, in un ordine cosmico di perfezione naturale. Nella sua Danza dell’Otto, dai movimenti precisamente codificati, ella comunica alle compagne la posizione di fiori, nettare, polline e sorgenti d’acqua, quasi a suggerire che, danzando, si può conoscere la Via della Vita. “Danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti”, sembra dire, come una piccola Pina Bausch. È una danza circolare, che mima l’otto, simbolo di infinito ed equilibrio cosmico fra dentro e fuori, movimento centripeto e centrifugo, tra il penetrare il mondo e il lasciarsi penetrare. L’ape ci appare come maestra perfetta dell’equilibrio fra il Bene ed il Male, nel suo veleno potente e pericoloso, ma regolatore infallibile dell’ardore e capace di divenire persino utile in carenza di calore, come nel caso dei reumatismi. Essa testimonia la presenza e la necessità del Male, ma solo in quanto male comune, nell’ultimo, definitivo gesto di amore per la propria comunità, un gesto di difesa, che è il pungere e che provoca la morte per lei stessa, quasi a significare che non c’è morte altrui che non sia anche la propria.
La cera e la ceroplastica.
La cera d’api, prodotto prezioso dell’apicoltura, è secreta dalle api operaie di età compresa fra i 12 ed i 17 giorni, per costruire le celle del favo, dove vengono allevate le larve e conservati il miele ed il polline. Per rendere biologicamente possibile la secrezione della cera, la temperatura dell’alveare deve essere compresa fra i 33 ed i 36 gradi. La cera d’api si presenta di un colore variabile, fra le tonalità del giallo oro e del bruno, a seconda della purezza della stessa e della tipologia di fiore scelto dalle api. Protagonista del laboratorio di terapeutica artistica confezionato su misura per il Signor V, sarà la cera vergine, disponibile nei classici pani e ottenuta dalla sola fusione con acqua calda, senza aggiunta di altre sostanze. Essa mantiene una particolare gradevolezza aromatica, dal sentore mielato e floreale. Da un punto di vista chimico – fisico, la cera d’api si presenta come un composto di diversi componenti, in particolare soprattutto di palmitati, acido palmitico, idrossipalmitati ed esteri oleati, formati da lunghe catene di alcoli alifatici. Essa è caratterizzata da ha un alto punto di fusione, compreso tra 62 e 64 gradi, non raggiunge l’ebollizione in aria, ma continua a riscaldarsi, fino ad infiammarsi, a circa 120 gradi.
Da un punto di vista dell’utilizzo umano, l’uso della cera d’api è testimoniato sin dall’antichità. Tracce di cera sono state rinvenute nei dipinti della grotta di Lascaux, come nell’Antico Egitto, dove essa era utilizzata nella costruzione delle navi e nelle tecniche di mummificazione. A tal proposito risulta interessante osservare che il termine “mummia” non è di origine egizia, ma deriva dall’arabo mum o moum, proprio con il significato di “cera”, che ricopriva i morti anche fra Persiani e Sciiti, per impedirne la decomposizione. Nel periodo Romano la cera d’api entrò di diritto nell’attività e nel settore artistico ed estetico, al preciso scopo di isolare dall’acqua i dipinti murali. Nella contemporaneità, la cera d’api trova applicazione in diversi ambiti, fra i quali la produzione di cosmetici, prodotti farmaceutici, lucidanti e alimentari. Il prodotto principe e più noto della cera è la candela di cera d’api, particolarmente apprezzata nelle chiese ortodosse, per il suo modo di consumarsi molto pulito, praticamente senza gocciolamento verticale, e fumo poco visibile. Anche dal punto di vista della combustione, la candela di cera d’api si differenzia da quella di paraffina, garantendo una fiamma più dorata, dalle tonalità calde, con variazioni cromatiche a seconda della stagione di provenienza della cera.
“Materia estremamente duttile, relativamente economica e di facile reperimento, la cera è stata, per migliaia di anni, utilizzata in modi diversi: sia come materiale di appoggio per alcune tecniche artistiche (ad es. fusione a cera persa, pittura ad encausto, applicazioni in cera a fini decorativi, finiture policrome su pietra e marmo, ecc.), sia come vera e propria materia scultoria per fondere o modellare figure a tutto tondo o bassorilievi. Infatti, nonostante gli scultori abbiano da sempre preferito dare forma a materiali dal carattere più nobile e duraturo, quali marmo, pietra, legno e metallo, l’importanza della cera nella storia della scultura è tuttavia innegabile”, scrive Maria Letizia Amadori in La ceroplastica in Sicilia (2011). Grazie alle sue caratteristiche di pulizia e stabilità, nel Rinascimento la cera d’api fu ampliamente utilizzata dagli artisti per la presentazione di bozzetti in scala ridotta e modelli per la committenza: si pensi in tal senso alle figure elaborate dal Tiepolo o dal Bandinelli per i monumenti funebri loro commissionati. Di particolare importanza risulta la fusione a cera persa, tecnica scultorea originariamente introdotta nell’età del bronzo, che nei secoli ha conosciuto una notevole fioritura, soprattutto nell’arte greca, romana e nella scultura monumentale. In epoca cristiana, la cera ha assunto anche un particolare ed importante valore liturgico, nel cero pasquale, negli ex voto e nell’Agnus Dei, una tavoletta di cera con l’immagine dell’Agnello Mistico sul recto e sul verso immagini di santi o lo stemma del Papa. Uso principe della cera d’api in ambito artistico è la ceroplastica, ovvero l’arte antichissima di modellare figure in cera, celebre già nell’ambiente romano, in particolare per creare ritratti di spiccata somiglianza con il soggetto, come nell’Antico Egitto, per la realizzazione di figurine a carattere magico e religioso, che sono entrate a far parte del corredo delle più celebri collezioni museali. Altro uso figurativo documentato è nella rappresentazione dei Lari, protagonisti della mitologia romana che rappresentano gli spiriti protettori degli antenati, per le bambole dei bambini, per le figure degli scacchi o latruncoli (soldatini di un gioco romano simile agli scacchi) e, con connotazioni esoteriche, nella creazione di feticci e figurine per i sortilegi. La ceroplastica, propriamente detta, si differisce sensibilmente dal semplice bozzetto di studio, “in quanto è praticata dall’artista con l’intento di realizzare un oggetto estetico e quindi accuratamente ornato, decorato e definito nel minimo dettaglio. La cera, infatti, a differenza dell’argilla o degli altri materiali impiegati in scultura, offre alla policromia un ampio ventaglio di possibilità di applicazione; come la pietra, il legno o la terracotta, essa può ricevere una pellicola pittorica così come una doratura o un’argentatura, oppure essere colorata nell’impasto così come il gesso, ma con risultati molto più variati e soddisfacenti. Così trattata, quindi, la cera è in grado di assumere un’incredibile verosimiglianza con il modello reale, sia esso una persona, un oggetto o un animale, grazie alla particolare morbidezza dei contorni e alla delicatezza delle sfumature”, puntualizza sempre Maria Letizia Amadori.
La vista: il giallo e il Sole.
Dal punto di vista artistico terapeutico, risulta particolarmente importante la sensorialità intrinseca della materia, da ripensare non solo in termini di semplice oggetto di manipolazione creativa, riconoscendole invece, al contempo, anche il ruolo di soggetto di creazione. La materia è oggetto e soggetto del processo creativo, esattamente come l’artista, in una reciprocità lacaniana di sguardo ed azione che, ancora una volta, racconta del perfetto equilibrio del ricevere e del darsi, poiché in un rapporto d’amore, e il rapporto artistico ne è puro esempio, il concedersi è sempre concedere all’altro e concedersi l’altro: nessuna perdita, se non pari alla vincita, e nessuna vincita, se non pari alla perdita.
Ogni materia, come ogni amante, ha il proprio linguaggio e un suo speciale modo di essere toccata e di toccare. Essa si lascia prendere, manipolare e risponde alle mani in una maniera specifica che le è propria ed unica. Prestare ascolto alla natura sensoriale della materia, agli inizi di ogni laboratorio artistico, è come un sinuoso studiarsi, vicendevolmente, sentirsi. Un primo appuntamento d’amore, dove le sensazioni tattili, olfattive, visive possano guidare e svelare la via che la relazione amorosa e artistica prenderà, poiché “il fiume modella le sponde e le sponde guidano il fiume” (Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente, 2010). Occuparsi di sensorialità è dare il tempo ai sensi di dare un senso al lavoro artiterapico. Il primo senso naturalmente coinvolto nel processo è quello della vista, che richiede un approccio cromatologico alla materia: il colore è una conquista che rivoluziona la visione del bambino (che si sviluppa completamente entro l’anno di età) e influisce tutta la percezione nell’età adulta. Dal punto di vista sensoriale, la prima caratteristica che la cera offre di sé è il suo colore giallo, che colpisce particolarmente la vista anche perché il giallo è il colore più distinguibile da lontano. Osservando la Natura, da un punto di vista zoologico, il colore giallo, soprattutto in unione al nero, è utilizzato per comunicare la propria pericolosità agli altri animali: l’abbinamento cromatico giallo-nero è utilizzato in questo senso dalle api, come dalle vespe e da animali marini tossici. Nel caso specifico dell’ape abbiamo già visto come la sua pericolosità si inserisca pienamente nel particolare contesto comunitario, nel quale il segnale di pericolo si presenta come nobile e umile volontà di difesa e cura della propria comunità, non immune dal lato di partecipazione olistica al dolore (con la morte dell’ape pungente). L’eredità naturale del giallo quale messaggio cromatico di pericolo e di necessaria cautela è riscontrabile anche nella società contemporanea come, ad esempio, nelle bandiere gialle delle corse automobilistiche, nelle condutture di gas come nella luce mediana del semaforo. Ma tracce di questo messaggio non verbale e dalle radici profonde sono riscontrabili anche nella lingua: si pensi ad esempio al giallo come genere letterario o all’uso nel dialetto napoletano, dove dicendo “ho fatto il giallo” si intende aver avuto molta paura, poiché questo è il colore dell’urina, legata ai reni, all’acqua e notoriamente alle emozioni.
Da un punto di vista etimologico, il giallo deriva dalla base indoeuropea ghel, col significato di “scintillante, luminoso” ed al contempo di “gridare”: il giallo infatti è “il colore che grida per ottenere attenzione” (Vebster’s NeV Vorld Dictionary of American English, 1988).
Da un punto di vista storico, il pigmento giallo ocra fu uno dei primi colori utilizzati nell’arte preistorica rupestre. La grotta di Lascaux ospita un fulvo cavallo di 17300 anni e nell’Antico Egitto il giallo fu associato indissolubilmente con l’oro e, simbolicamente, all’eternità, e per questo utilizzato ampliamente nelle decorazioni funebri. Da un punto di vista spirituale e religioso, il giallo è il colore maggiormente sacro nel Buddismo, dove le vesti dei monaci testimoniano la scelta della rinuncia al mondo esterno per onorare un sentiero di saggezza e, ovviamente, di illuminazione, ovvero di passaggio dal Buio alla Luce. Nel Cattolicesimo il giallo è ancora una volta legato all’oro e al Paradiso e, in associazione al bianco, alla Resurrezione. Il giallo è simbolicamente legato al Terzo Chakra, ovvero al Plesso Solare, strettamente correlato con la volontà, le emozioni e sentimenti. Nella Cromoterapia, esso è considerato in relazione con la parte sinistra del cervello e particolarmente impiegato (anche attraverso l’uso della cromopenna) come stimolante intellettivo.
La cera porta in dote il colore del Sole, divenendo simbolo del puro oro estivo, come il miele. Essa incarna la luce gialla ed è essa stessa, attraverso la declinazione della candela, luce materiale e materia di luce. Non rappresenta la luce bianca, paradisiaca e inafferrabile, ma bensì quella gialla, tangibile e terrena. La luce gialla della cera sta alla luce bianca e pallida della Luna, come la speranza della reincarnazione o della resurrezione del corpo sta alla speranza della resurrezione dell’anima: la luce della cera è fatta di carne e sa di terra e ci parla dell’Esserci e del mostrarsi come si è, vivacemente. La gioia del Giallo rende la cera amabile anche a prima vista e ispira un lavoro terapeutico artistico sulle orme di questa lietezza solare. È difficile immaginare un laboratorio artistico mesto e malinconico, con la cera vergine, così ricca di sole: la cera stessa indica la sua via naturale ed è una via di luce.
In relazione alla cleptomania e da un punto di vista strettamente cromatico, la cera d’api si presenta come materia di luce e veicolo di visibilità gioiosa, rispondendo al particolare bisogno del paziente cleptomane di autoaffermazione e di ricchezza propria. Mimando il colore dell’oro, essa diviene moneta naturale di prosperità, spendibile in termini di rinnovata autostima.
L’olfatto: profumo di miele.
La cera d’api reca con sé il ricordo odoroso del miele, è memoria incarnata del miele: ai bimbi viene istintivo il desiderio di assaggiarla, in fase laboratoriale, e coinvolgere in tal senso anche il gusto, nell’estasi di assaporare il giardino e sentire il sapore del fiore. Nell’aromaterapia, le fragranze ispirate al miele (come l’assoluto delle cere d’api, estratto con l’alcool delle vecchie cere dell’arnia) vengono usate per richiamare la dolcezza e il nutrimento spirituale, l’armonia e il libero flusso emotivo.
Lavorare artisticamente con la cera d’api, dal punto di vista olfattivo, equivale a lavorare col miele: attraverso il senso dell’olfatto, con la cera è possibile fruire delle proprietà aromaterapiche del miele, sperimentandone in particolare l’effetto protettivo e nutritivo del suo aroma, in particolare a livello emotivo.
In relazione alla cleptomania l’aroma del miele risulta di particolare interesse: la dolcezza dell’aroma nutre a livello emotivo, richiamando anche inconsciamente il tempo della dolcezza assoluta, ovvero quella del latte e del neonato, che sperimenta la nutrizione in termini di dolcezza del gusto. Accettando l’ipotesi psicoanalitica nella cleptomania di un “vuoto originario” che porterebbe a un patologico desiderio di “riempirsi di beni altrui”, un aroma (come un sapore) che tenda a colmare e appagare emotivamente potrebbe partecipare, a livello sensoriale, al trattamento della patologia stessa. In relazione alla cleptomania e in particolare ai suoi impulsi forti e compulsivi, è da considerare anche l’aspetto rilassante e calmante dell’aroma del miele. Da un punto di vista aromatico, la cera d’api si rivela in questo senso una dolce risposta olfattiva e sensoriale al bisogno di riempire il vuoto del paziente cleptomane, mostrandosi in tutta la sua preziosa potenzialità terapeutica.
Il tatto: il giusto tempo e la giusta temperatura.
A temperatura ambiente, la cera è particolarmente ricettiva al graffio, all’incisione ed al taglio, anche se risulta scarsamente manipolabile. La sua consistenza varia tuttavia a seconda della temperatura e quindi, anche semplicemente riscaldandola fra le dita, fino a giungere a una temperatura attorno ai 35 gradi , la cera diviene più accomodante al gesto delle mani, malleabile e plasmabile. Allo stato liquido, la cera è particolarmente stabile, con bassa vischiosità. Nella colatura la cera incarna l’immaginario dell’oro fuso, prezioso e intoccabile: pena una scottatura d’avarizia. Ma nel lento processo di raffreddamento essa guadagna la consistenza della pelle virginale, morbida, tiepida e liscia, tanto da convincere il Canova a colarla su alcune sue opere, per diventare pelle artistica delle sue vive statue di marmo.
La consistenza della cera d’api veicola, dal punto di vista tattile, il mistero della trasformazione, legata in particolar modo alla temperatura. In relazione alla cleptomania, la sensorialità tattile della cera d’api testimonia la preziosa relazione fra forma e calore, divenendo portavoce della variabilità delle risposte rispetto all’ambiente. La consistenza variabile della cera suggerisce all’artista e al paziente di cercare la giusta temperatura, quella perfetta per comunicare con le mani, o con gli strumenti dell’arte, e per giungere al perfetto rapporto artistico e rapporto d’amore. La cera tocca e si lascia toccare parlando di malleabilità mediana, di concessione equilibrata e di reciprocità. Parla dell’amore equilibrato, della tenerezza che permette la creatività e del binomio prendere/dare sempre con delicatezza, per non cadere nella materia spezzata, nella scottatura o nel dialogo muto e sterile della frettolosità.
La cera e la relazione con gli elementi.
Da un punto di vista tattile e manipolativo, la cera assomiglia all’argilla, essendo rimodellabile in corso d’opera, e al contempo fornisce alcuni vantaggi, come la scarsa tendenza a fendersi o ritirarsi, nonché la sua lavorazione relativamente pulita. Dall’argilla la cera eredita il rapporto con l’elemento Terra, in particolare con le sue caratteristiche di forza, lavoro e creazione (Gaston Bachelard, La terra e le forze. Le immagini della volontà, 1989). La cera parla della laboriosità operativa dell’uomo, della sua capacità di trasformazione del mondo esterno, attraverso le proprie mani.
La cera, sorella del miele, è in relazione anche con la rugiada e con l’elemento Acqua (Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque, 2006), in particolare col rapporto archetipico madre/infante e con il tratto della fluidità. La cera, alla giusta temperatura, incontra l’elemento acquatico, nelle sue connotazioni primordiali di liquido amniotico, brodo primordiale, caldo e dolcemente protettivo.
La cera ha anche un naturale rapporto con l’elemento Aria, essendo figlia prediletta del volo dell’ape (Gaston Bachelard, Psicanalisi dell’aria, 2007). Dell’Aria essa risveglia il corollario onirico del volo libero, anche nelle sue connotazioni ascendenti e, quindi, di ascesa emotiva e spirituale.
La cera, nella sua genesi evolutiva, si sposa a livello storico e archetipico con l’elemento Fuoco, essendo indissolubilmente legata alla realtà e al simbolo della candela La cera è portatrice di immagini di luce, calore, nonché trasformazione, che trascende da quella operativa delle mani, più legata all’elemento Terra, per evocare maggiormente una trasmutazione spirituale, attraverso il Fuoco, protagonista degli arcaici passaggi di iniziazione, che inaugurano nuove stagioni di vita, attraverso un processo di morte e rinascita (Gaston Bachelard, L’intuizione dell’istante. Psicanalisi del fuoco, 1993).
Colatura e dripping: la Carta Geografica.
La cera d’api può essere sciolta in un pentolino, a fuoco particolarmente lento, oppure a bagnomaria, data la sua alta infiammabilità. Una volta sciolta, la si toglie dal fuoco ed è possibile con essa effettuare le prime prove di colatura, ad esempio, su fogli di carta. Appena allontanata dal fuoco e quindi ad una temperatura ancora alta, almeno attorno ai 60-70 gradi, la cera è pienamente sciolta, ha la consistenza e il colore del caramello. Gli effluvi dolci del miele sono esaltati dalla temperatura e dai fumi densi. Se colata ad alta temperatura sulla carta, la cera guadagna lo spazio bianco alla velocità del latte e imbarca la carta, per calore e umidità. Ma se si attende qualche minuto, la cera, raffreddandosi, inizia a perdere la liquidità in favore di una qualità fluida e spumosa.
Il laboratorio artiterapico inizia con una prima fase d’avvicinamento alla materia e analisi istintiva, soprattutto visiva, tattile e olfattiva, della stessa, per poi passare a una prima fase operativa, fatta di colature e gocciolamenti alla scoperta delle diverse temperature e densità.
L’esperienza della colatura è in relazione con la tecnica del Dripping, caratteristica dell’Action Painting americana, traduzione pittorica della scrittura automatica surrealista, elaborata in particolar modo alla fine degli anni Quaranta, da Jackson Pollock. Laboratori di dripping sono ampiamente utilizzati nell’ambito della terapeutica artistica, soprattutto per la capacità di autodeterminazione dell’opera, che si crea in macchie, accostamenti e sovrapposizioni di colori. Accanto alla casualità della sgocciolatura, il dripping ha spiccate connotazioni terapeutiche grazie al particolare coinvolgimento del corpo, il cui movimento partecipa attivamente all’autodeterminazione dell’opera, per la quale materia gocciolante e artista divengono coppia creatrice. Così come il colore può essere lasciato gocciolare sulla tela, anche la cera può essere versata a gocce, sperimentando le sue diverse densità e fluidità legate alla temperatura. Nella prima fase operativa laboratoriale, rivoli e gocce di diverse sfumature di giallo sono colate e versate su fogli di carta di varia grammatura: ne risultano stratificazioni differenti in gradazioni e trasparenze, che suggeriscono allo sguardo sognante immagini, disegni nascosti e suggestioni di paesaggi ondulati e dalle dune dorate. In questa rêverie, che si eleva come una piacevole e misteriosa arcomanzia su cieli di tramonto, nascono illustrazioni dai racconti dell’anima: farfalle, infiorescenze, vedute di mondi. Una delle prime figure riconosciute dal Signor V. nelle colature in fase di solidificazione, e che resterà ben salda nella sua memoria , è una carta geografica. Una volta titolata così, essa mi ricorda vagamente la curvatura della penisola italiana, ma al contempo, anche una madre con un bambino e sperimento personalmente e fortemente la labilità dolce del confine tra l’immaginario dell’artista e quello dell’artista terapista. Se fare arte è scoprire la rêverie, il “sognamento” e se è essa un modo di sognare a occhi quasi sempre aperti, è interessante soffermarsi sul possibile significato del sognare o intravedere nella cera colata una carta geografica o una mappa. Ogni mappa indica una via e una direzione, ogni carta geografica delinea uno spazio. In tal senso il sogno di cera potrebbe raccontare il desiderio di cercare una strada, uno spazio o dei riferimenti con cui orientarsi. La prima fase operativa del lavoro con la cera lascia in eredità un indizio simbolico, la Carta Geografica, da spendere e ritrovare nelle mai finite letture dell’opera, che si arricchisce di nuova luce, come un’iride che svela sfumature cromatiche, di pioggia in pioggia.
La poetica del graffio e la cleptomania pentita.
Dopo l’iniziale fase di colatura ed arcomanzia sulle prime opere, il laboratorio passa gradualmente a un secondo momento di lavoro, che prevede un’azione sulla cera colata, che si traduce inizialmente con un semplice coinvolgimento del corpo: piccole impronte di dita e polpastrelli impresse nella cera piacevolmente tiepida. Nascono firme delle mani, una prima affermazione di sé, un sigillo d’amore fra corpo e materia. In questa fase assume particolare importanza la tattilità dell’esperienza artistica, con tutta la sua portata di piacevolezza. La cera colata, lasciata raffreddare, diventa tiepida, liscia in superficie, vera pelle di un corpo di dolcezza, tutta da accarezzare e accudire. Essa sembra incarnare la pelle quale “luogo privilegiato dell’attenzione e delle cure degli adulti nei confronti del bambino” (Anzieu Didier, L’Io-pelle, 1996).
La pelle non è il regno solo della carezza, ma anche dei gesti di violenza espressiva. Nell’ottica di una ricostituzione dell’unità giallo-nero e luce-ombra e di una legittimazione di quest’ultima, come parte integrante e da integrare, nella complessità dell’individuo e dell’archetipo, la carezza può lasciare lo spazio, nel setting sicuro del laboratorio, gradualmente, al graffio. Il duplice gesto della carezza-graffio, così simile al mistero amoroso felino, per il quale il graffio segue le fusa e le fusa seguono il graffio, coglie pienamente il simbolo, nel suo primitivo significato etimologico di symbállō ovvero “mettere insieme”, del gesto sulla pelle. Dal graffio con l’unghia, sulla cera tiepida o fredda, si passa all’utilizzo di strumenti che prolunghino l’intenzione del corpo: rametti raccolti nel bosco, posate e matite, giungendo quasi a un’operazione di autopsia della materia, dai tratti drammatici e al contempo grotteschi. Il Signor V. sperimenta diversi oggetti nelle attività di graffio e incisione della cera, abbandonandosi al graffio in modo incerto e tendendo sempre a ripristinare quello che evidentemente considera come un disordine espressivo, raccogliendo i grumi di materia erosa e riposizionandoli sopra le parti graffiate. Il gesto di graffiare e riposizionare grumi e briciole di cera, in un rito altalenante di togliere e mettere, privare e restituire, mi ricorda la tenerezza della cleptomania pentita, che ruba per poi riportare al legittimo proprietario, con vergogna ed imbarazzo: è proprio così che il Signor V. ha imparato a fare, soprattutto nella nuova casa di Museis, dove restituisce i piccoli oggetti del suo irrefrenabile desiderio, incontrando il sorriso, un po’ burbero ma sempre accogliente, dei suoi responsabili.
Mi rendo conto che l’azione del graffiare, che appare con spiccata casualità (o causalità?) vicina all’ambiguo e duplice termine di grattare, non soddisfa particolarmente il Signor V. che, anche nel graffio, come nella colatura, cerca qualcosa di ordinato. Partendo dal graffio, la mano quindi gradualmente e naturalmente, inizia a sperimentare l’incisione, un atto più palese e profondo, che chiaramente incontra maggiormente il piacere del Signor V. L’artista inizia a ritirarsi maggiormente nella sua postazione defilata, passa importanti frazioni di tempo da solo, con tavolette di cera da incidere in maniera sempre più estetica e simbolica, in un’autopsia ordinata che inizia a svelare, senza dolore, qualcosa di interno e meraviglioso. La cera è incisa sempre tiepida, per evitare l’effetto polveroso del graffio a cera fredda. Le linee diventano chiare espressioni del gesto. L’autopsia graffiata diventa simbolo e poi scrittura, senza quasi accorgersene.
La scrittura e la casa.
La tavoletta cerata fu un noto supporto scrittorio dell’antichità, il cui uso era comune in tutto il territorio dell’Impero Romano, testimoniato anche nel Medioevo. Il testo era tracciato a graffio con uno strumento apposito, detto “stilo” e la cera poteva essere raschiata e successivamente ridepositata, permettendo una cancellazione del testo scritto nonché un eventuale riuso del supporto. L’uso delle tavolette cerate era anche proprio dei dittici consolari, tavolette in avorio, cerate all’interno e scolpite all’esterno, offerta che consoli e magistrati romani donavano ad amici e parenti, in occasione della propria nomina. Il gruppo più antico di tavolette cerate risale al I secolo d.C. e fu rinvenuto a Pompei.
La scrittura è ampiamente usata in ambito terapeutico, sia psicoanalitico che artistico terapeutico. In quest’ultimo contesto si tratta perlopiù di scrittura autobiografica, ma si comprende con semplicità che ogni scrittura è, in un certo modo e misura, autobiografica, allo stesso modo in cui ogni personaggio onirico parla di noi, ovvero è una nostra proiezione personale. La scrittura, in ambito terapeutico, promuove una salutare rielaborazione cognitiva ed emozionale della propria vita, divenendo fertile processo di auto svelamento (Lorenzo Cantoni, Nicoletta Di Blas, Teoria e pratiche della comunicazione, 2002). Secondo la ricerca scientifica, la scrittura è in grado di modificare lo stesso stile del comportamento, oltre a offrire una maniera aperta e diretta di parlare di se stessi (simile in tal senso alla comunicazione non verbale del gesto e del movimento corporeo), ma soprattutto permette una potenziale riorganizzazione dei pensieri e delle emozioni (Ricci Bitti Pio E. Cortesi Santa, Comportamento non verbale e comunicazione, 1977).
Il momento della scrittura è vissuto dal Signor V. in stretta comunione con l’esperienza della tela: piccoli telai rettangolari ospitano le sue prime scritture cerate che, ancora una volta, esprimono la sua particolare carta geografica interiore, dedicando i propri testi alla sua “casa del cuore”, ovvero al Bosco di Museis. Il paziente-artista decide di creare delle targhe per la fattoria sociale, che donerà al responsabile, Renato Garibaldi. Nascono diverse tavolette cerate, con la scritta “Agriturismo Bosco di Museis”: non “Fattoria Sociale Bosco di Museis”, ma semplicemente “agriturismo”, con tutta la naturale e chiarissima voglia di normalità che nella fattoria vige come regola prima. Su qualcuna di queste tavolette approda qualche foglia decorativa, un rametto avanzato dai gesti del graffio, un fiore. Ancora una volta il passaggio esperienziale nel laboratorio avviene gradualmente e senza particolare direttiva, ma con un ritmo interiore che si autogenera. Dalla scrittura si passa all’assemblage, un nuovo passo, dal sapore surrealista, nella cera e nella terapeutica artistica.
L’assemblage: colla e glassa solare.
L’assemblage è una tecnica artistica di composizione tridimensionale, in stretta parentela con il collage. L’origine del termine è da attribuire a Jean Dubuffet che, agli inizi degli anni Cinquanta, propose una serie di collage intitolati Assemblages d’Empreintes. Le tecniche dell’assemblage e del collage sono utilizzate negli atelier di terapeutica artistica, a volta col nome di psico-collage, in particolare per le spiccate potenzialità di rimettere insieme, ricomporre, in un invito kandinskijano a rimarginare le ferite coi colori.
Nella sua esperienza artistica e laboratoriale, il Signor V. passa gradualmente dalla scrittura all’assemblage, incorporando sempre più materiali sulle tele e rinunciando, gradatamente, alla parola scritta. Scegliamo per i nostri assemblage materiali che reperiamo sul luogo: il paziente-artista è libero di girare per la fattoria e al limitare del bosco per scegliere autonomamente i propri oggetti da assemblare. La cera questa volta funge da potente colla solare, inglobando e cristallizzando al contempo il materiale vegetale e divenendo infine glassa solare di copertura, per i dolci prodotti dell’attività delle mani. Nascono opere spiccatamente materiche, spesse di desiderio, dove il legno, le erbe, le mele selvatiche raccolte dal giardino si incorporano in un tutto armonico. Il Signor V. crea opere dal sapore rurale, nuove fotografie chiare di Museis, dove gli steccati aperti parlano di protezione e libertà e le infiorescenze di primavera sono brulicanti di desiderio: sono opere a colori, con lo sfondo giallo della cera estiva, che garantisce il Sole in queste fotografie interiori. Il Signor V. ne è orgogliosissimo: desidera una foto per ogni assemblage, dice che li regalerà, a Garibaldi e a qualche amica.
L’opera condivisa: l’alveare d’oro.
Camminando verso la stagione più matura del laboratorio e contando gli strati sempre più corposi e audaci degli assemblage, il gruppo di lavoro si allarga, accogliendo bambini e altri utenti della fattoria sociale e inizia a immaginare un’opera condivisa, per cui abbiamo a disposizione sette particolari tele, a forma esagonale. Ho scelto questa forma in onore della configurazione, naturale e archetipica, delle celle di cera di cui sono costituiti i favi degli alveari. La scelta di una forma geometrica così particolare da parte dell’ape potrebbe indurre a pensare a una bizzarria della Natura, tuttavia, come bene insegnano l’esperienza e le scienze naturali, nulla in Natura è semplice caso ed è nelle speciali proprietà dell’esagono che risiede l’origine di questa scelta del mattone costitutivo della loro complessa ed evoluta architettura urbana. Nell’esagono le api hanno scoperto un ottimo compromesso fra l’intenzione di risparmiare materiale costruttivo e la necessità di allargare lo spazio all’interno del favo. La figura geometrica che ha, a parità di perimetro, un’area maggiore è il cerchio, seguito dai poligoni con più alto numero di lati. Considerata questa proprietà geometrica, se le api costruissero celle isolate, la forma circolare sarebbe sicuramente quella che garantirebbe al contempo maggior risparmio di materiale e guadagno di spazi. Un favo tuttavia ospita molte celle e la forma circolare creerebbe dei vuoti di spazio fra le stesse che sarebbero inutilizzabili. L’esagono risulta quindi, alla luce delle esigenze e dei fatti, il miglior compromesso fra un cerchio e un poligono, poiché è la figura col più alto numero di lati che riesce al contempo a riempire uniformemente lo spazio e a permettere un alto risparmio di materiale costruttivo. Ogni lato della cella è infatti in comune con un’altra cella del favo. Da un punto di vista simbolico, l’esagono risulta essere una delle figure magiche più antiche del mondo: Pitagora lo considerava l’unione di due triangoli incrociati, simbolo della creazione, per gli Antichi Egizi rappresentava la congiunzione di Fuoco ed Acqua, connubio di generazione, in ambito essenico la figura diviene il Sigillo di Salomone, lo Scudo di Davide per gli Ebrei e per gli Indù il Segno di Vishnu.
Con le sette tele esagonali, decidiamo di creare un’opera condivisa con l’intero gruppo di lavoro, che contempli le diverse esperienze provate di colatura, scrittura ed assemblage: ne nasce un esagono condiviso fatto di sette tele esagonali, con gocce di cera, mele selvatiche, petali, rametti e qualche scrittura che si improvvisa negli spazi bianchi della tela. L’condivisa parla delle sensazioni del laboratorio, recando in sé la varietà degli sguardi, dei gusti e degli umori, è un’opera colorata, allegra, un assemblage variopinto dal sapore squisitamente estivo. Il responsabile Renato Garibaldi desidera esporla in modo permanente nel piccolo negozio dell’agriturismo: prendiamo le misure dell’esagono condiviso e creiamo un supporto di legno in grado di sostenerlo, con il costante aiuto e supporto della falegnameria. La prima opera condivisa si presenta come un alveare d’oro della condivisione artistica e viene appesa all’entrata del negozio, sotto lo sguardo soddisfatto dei partecipanti e soprattutto del Signor V., che nei mesi a venire si premurerà di presentarla agli ospiti dell’agriturismo, perpetuando favorevolmente l’orgogliosa sensazione della creatività e della creazione.
La candela: operosità luminosa.
Una seconda fase del laboratorio si apre in seguito all’installazione della prima opera condivisa: il lavoro è in questa fase ricondotto alla coppia artista-artista terapista. Il passaggio dal lavoro di gruppo al lavoro di coppia (e dal gruppo di lavoro alla coppia di lavoro) reca con sé diversi processi naturali di cambiamento: la pluralità di voci, spesso corale, si trasforma in un dialogo a due, dove il filo del pensiero si passa di bocca in bocca e di occhio in occhio, con un ritmo duale e cadenzato. L’esperienza prevista per questa fase più intima e defilata è incentrata sulla luce, attraverso la creazione di candele di cera d’api. Questa fase di laboratorio è particolarmente ideata per rispondere ad un’esigenza fondamentale per il Signor V., ovvero diventare autonomo in alcune attività all’interno della fattoria: risulta di importante interesse terapeutico per lui entrare operosamente e in prima persona nelle attività anche pratiche ed economiche della fattoria, divenendo attore e protagonista del processo della produzione di beni e di bene, partecipando attivamente alla funzione produttiva della fattoria, scegliendo al contempo un’attività dai risvolti creativi e piacevoli.
Creare una candela significa primariamente sognarne la forma. Perché la cera colata s’adatta alle idee della forma, come latte d’oro in un bicchiere. Il Bosco di Museis ha messo a disposizione molti stampi in silicone, usualmente utilizzati per la produzione e vendita di candele, in associazione ai prodotti dell’apicoltura. Una volta scelto lo stampo da utilizzare, è necessario prepararlo alla colatura della cera. Lo stampo si presenta tagliato a metà per favorire l’inserimento dello stoppino e la successiva liberazione della candela, una volta solidificata. Inserito lo stoppino, è necessario chiudere lo stampo, per non disperdere la cera che esso ospiterà, lo si può assicurare con degli elastici molto stretti, che sono facilmente rimovibili in fase di liberazione della candela. È poi necessario fissare lo stoppino, utilizzando coppie di stecchetti di legno che ne assicurino la posizione verticale. Una volta preparato lo stampo è sufficiente colare con cura la cera calda all’interno dello stampo e attenderne il raffreddamento e la solidificazione. I tempi di solidificazione della cera dipendono molto dalla forma di candela scelta, ma è sufficiente prestare attenzione alla temperatura dello stampo per capire il momento giusto per sfilare la candela: quando lo stampo è completamente freddo, la candela si stacca con facilità dallo stesso, conservando la precisione dei dettagli e la sicurezza della forma.
Il Signor V. sperimenta tutte le fasi della creazione della cera, dalla scelta degli stampi alla preparazione degli stessi, dalla colatura della cera calda all’estrazione della candela creata. Moltissime candele sono create in questa fase del laboratorio e il paziente-artista, fra una colatura e l’altra, racconta a chi desidera regalare le candele: un fratello, un’amica, una negoziante gentile. La restante parte delle candele create servirà per una seconda opera condivisa, un sogno lucido di luce boschiva.
Una seconda opera condivisa: luci nel bosco.
Nasce la seconda opera condivisa del laboratorio, in una notte d’agosto, davanti a 200 spettatori, curiosi e partecipi, nell’ombra illuminata del Bosco di Museis. È una calda vigilia di Ferragosto, ideale per ricordarne le antiche radici storiche, che affondano nel desiderio ridente e solare di festeggiare i raccolti e i frutti del proprio lavoro e fatica. Il bosco porta in dote la frescura del fogliame, una corolla di alberi si staglia verso le stelle estive, creando un teatro naturale, a cielo aperto. Decine di candele, forgiate dalle dita ormai sicure del Signor V, si consumano tracciando un sentiero luminoso fino al cerchio d’alberi. È proprio il Signor V a donare la prima luce ai presenti, ricco di esperienza e di preziosa cera d’api, ormai affine e conosciuta. Fiamme robuste di falò in tronchi cavi contribuiscono alla luce e l’ombra danza, di conseguenza, fra il muschio e il fumo, sotto lo sguardo di donne, bambini, esseri visibili e invisibili. Qualche anziano è accompagnato, a braccia, nel saliscendi del terriccio. I bimbi mormorano e ridono piano. Tutti sono ormai posizionati nel cerchio d’alberi, che straborda sul pendio, improvvisato di sedie di legno e coperte. C’è una ballerina, un’attrice, un cantastorie e un’arpista, un falò mediano, Re della Luce, cui tutte le nostre candele guardano. Alla luce delle candele del Signor V. si consumano racconti, canzoni, improvvisazioni di danza nella penombra boschiva. La lingua è il friulano, l’inglese è l’italiano, nonché quella delle lingue di fuoco, che crepitano a ritmo tribale. L’opera è un tutt’uno di sguardi, spettatori, artisti, bosco, ogni cosa si guarda e guarda al Fuoco, centro di creazione e centro estivo di luce d’oro.
Da un’intervista finale al Signor V.:
Come descriveresti la cera d’api?
La cera d’api è come la forma di formaggio:
la tagli a metà, la metti nel pentolino.
Che cosa hai scelto di fare con le tue opere?
Una l’ho regalata alla responsabile della comunità, li altri li ho regalati a Renato.
Una l’ho data a Debora.
Vorresti fare un altro laboratorio artistico?
Mi piacerebbe molto. Sempre con la cera.
Se c’è Vito può fare anche lui le candele.
Dalle parole del Signor V, possiamo certamente intuire come la luce si diffonda attraverso il dono e la condivisione, passando per una visione semplice, autentica e limpida delle cose, come una fetta di formaggio nel pentolino.